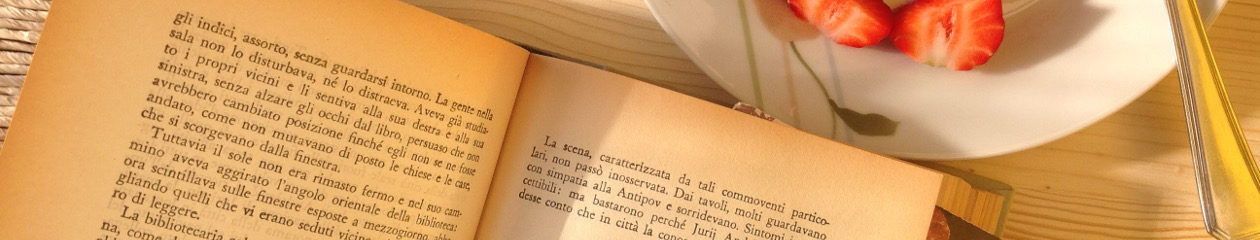L’agnello pasquale
Il flauto nel bosco, 1923
Il ragazzo stava seduto a studiare, ma tendeva l’orecchio per sentire se il padre tornava, perché al padre, terrazziere alla giornata spesso disoccupato avevano finalmente promesso un posto fisso, e da questo dipendeva forse l’avvenire del figlio.
Ci si erano messi di mezzo i preti, perché il terrazziere era un uomo religioso fino alla semplicità; e dunque si sperava in bene. Infatti l’uomo tornò a casa con un viso beato: aveva ottenuto.
Aveva ottenuto un posto di aiutante interramorti con lo stipendio fisso di lire cinquecento al mese, oltre le mancie.
La moglie lo guardava con ammirazione incredula, tanto la cosa, cioè lo stipendio fisso, le pareva straordinaria e bella: il resto non la riguardava.
Il ragazzo, invece, voltosi sulla sedia ad ascoltare, s’era fatto rosso su una guancia e pallido sull’altra. Il sangue gli andava su e giù su e giù come l’acqua entro la bottiglia che la madre sciacquava: perché infine egli avrebbe preferito esser figlio di boia piuttosto che di becchino.
Come si fa, d’altronde, a vivere? Vivere bisogna, e dalle beffe dei compagni ci si salva coi pugni e i sassi ben tirati. Questo proposito non lo sollevò: il sangue continuava a ribollirgli in corpo, a tingere di rosso le pagine del libro. Con un calcio mandò indietro la sedia; trasse di tasca il fazzoletto tirandolo quanto era lungo e se lo legò intorno alla fronte come quando la testa gli doleva per il troppo studiare; poi si affacciò alla finestra.
Giù la strada nuova appena fornita di ghiaia gli offrì per confortarlo quanti sassi voleva; e duri turchini aguzzi come scheggie di metallo: si poteva con essi abbattere tutto un esercito nemico. Ma non era questo che più lo preoccupava: in fondo non gl’importava nulla dell’opinione dei suoi compagni, i quali, del resto, avevano anch’essi le loro magagne, e chi era figlio di scopino di strada e chi di lavandaia: uno aveva il padre in carcere, un altro la madre donna perduta. Con un sasso e una parolaccia si mettevano a posto; ma quello che più lo di sprezzava non si poteva far tacere, no, perché quello era lui in persona.
Un avvenimento giù sotto la finestra lo distrasse.
Di là della strada appena finita si stendevano ancora i prati col gregge al pascolo, sebbene si fosse al confine della città. Il tramonto di marzo, con rosse nuvole dietro i mandorli fioriti, coloriva le cose.
Faceva caldo, e nell’aria e nei prati c’era un senso di febbre come quella che nei fanciulli viene chiamata febbre di crescenza. Il ragazzo dunque vide un piccolo agnello nero con le gambe ancora storte sbucare dalla siepe e aggirarsi smarrito nella strada rispondendo coi suoi belati infantili ai grossi belati del gregge: e dapprima agitò il fazzoletto che s’era strappato dalla testa, poi si sporse fischiando, infine scese di corsa nella strada.
Qualche cosa d’insolito accadeva nel prato. Il piccolo pecoraio, montato sull’asino che serviva di guida al gregge, correva di qua e di là da una siepe all’altra, destando uno smarrimento di follia nelle pecore che cercavano di seguirlo e tornavano indietro e si cozzavano e si urtavano con un subbuglio di onde in tempesta.
I ragli dell’asino e gli urli del pecoraio impazzito risonavano fra il belare disperato delle povere bestie che si chiamavano fra di loro e chiamavano i figli dispersi: un’ondata di polvere e di cattivo odore arrivava fino alla strada.
– È primavera – disse il ragazzo all’agnellino nero, rincorrendolo lungo la siepe. E quando l’ebbe preso lo sollevò e se lo portò a casa.
Questa casa era un antico cascinale di contadini che una impresa per costruzioni aveva cominciato a
demolire sospendendo poi i lavori e lo sfratto intimato al terrazziere. Il ragazzo portò dunque l’agnellino in quella che un tempo era la stalla, lo depose entro la mangiatoia e chiuse la porta perché non se ne sentissero i belati. E non sapeva perché facesse tutto questo: forse per svagarsi da quel pensiero del padre; forse spinto dall’istinto di compiere una cattiva azione per far dispetto al padre scrupoloso fino a non volere che si cogliesse neppure l’erba nei campi altrui e quindi restava un miserabile, un becchino.

L’agnello continuava a piangere, a chiamare la madre.
Aveva messo le zampette anteriori sull’orlo della mangiatoia e sporgeva la testa ricciuta, ma non osava e non poteva saltare giù. Il ragazzo lo guardava con cattiveria e con tenerezza:
– Mi sembri un predicatore sul pulpito – disse accarezzandolo sul dorso.
E metti giù le zampe e sta zitto, figlio di un cane. Adesso ti porto un po’ d’erba; poi, se stai buono più tardi ti riconduco da tua madre. E se non la smetti ti strozzo.
Tirò fuori di nuovo il fazzoletto e lo attortigliò in lungo formandone una specie di corda: poi lo
rimise in tasca e andò a cercare l’erba avendo cura di lasciare la stalla aperta onde far credere, se si scopriva l’agnello, che vi era entrato da sé.
Dalla strada ascoltò se si sentivano i belati: si sentivano, ma confusi con quelli del gregge che s’era
tutto accostato alla siepe come un a nuvola che scende all’orizzonte.
Il pecoraio restava però in fondo al prato e parlava con una donna che stendeva grandi lenzuola candide lungo la siepe opposta; e l’asino, lasciato libero, si avvoltolava per terra, di qua e di là, di qua e di là, con la pancia grigia all’aria, ragliando forte.
E il ragazzo, con un ciuffo d’erba in mano, si mise a imitare quell’urlo rauco e fischiante che irrideva la tristezza smarrita delle pecore, la storditaggine del pecoraio e la letizia del tramonto primaverile.
L’agnello rifiutò l’erba, rifiutò il latte che il ragazzo andò a prendere di nascosto della madre e gli porse in un piattino come si usa coi gatti piccoli. Non voleva nulla, l’agnellino nero; voleva la madre, e tendeva l’orecchio al lontano belare del gregge sbattendo le corte palpebre sugli occhi velati di terrore.
Il ragazzo lo riprese fra le braccia, cullandolo alquanto, sfiorò la guancia sul vello morbido che odorava di caglio, e pensò di riportarlo fuori: poi lo ripose nella mangiatoia. Aveva paura che il pecoraio lo vedesse.
– Più tardi, eh? – promise sottovoce, chinandosi sulla mangiatoia.
E con sorpresa vide che l’agnello si piegava sulle zampe e s’accovacciava, rassicurato dalla promessa. Allora tornò su in casa lasciando la stalla aperta.
Più tardi il padre e la madre uscirono. Andavano a prendere possesso dell’importante ministero di lui. Il ragazzo promise di stare a casa, a studiare: e da studiare ce n’aveva, poiché erano gli ultimi giorni delle vacanze di Pasqua; ma non gli riusciva più di riaprire il libro.
Si affacciò di nuovo alla finestra, e vide quei due che se ne andavano per la strada turchina, lui piccolo come un ragazzo, vestito in colore della terra, un po’ curvo e con le mani giunte come un fraticello; lei alta con le vesti che le cadevano giù per la magrezza e i capelli grigi sbiaditi più che dall’età dalla miseria e dalla debolezza: anche di lontano si sentiva la sua tosse.
Egli voleva bene alla madre, e quella tosse lo perseguitava giorno e notte. E sapeva ch’ella aveva bisogno d’aria di mare, e non d’aria di cimitero. E anche lui aveva bisogno d’aria di mare: invece quando quei due tornerebbero a casa puzzerebbero di morti.
Con chi pigliarsela, d’altronde? – Viva Lenin – gridò dalla finestra. E il belare delle pecore gli rispose.
La sua rabbia era tale che sentì il bisogno di stringersi di nuovo la testa col fazzoletto ancora attorcigliato, poi dalla fronte se lo calò alla bocca, e infine se lo strinse al collo in modo da farsi venire un urto di vomito.
Gli pareva d’impazzire, come il pecoraio, l’asino,le pecore stordite; come tutte le erbe e le foglie che adesso si agitavano al vento.
Più tardi vide il pecoraio che mandava avanti l’asino giù per il varco della siepe e aizzava poi le pecore a seguirlo. Ma solo quando il cane si alzò sbadigliando dal posto dove aveva creduto bene di sonnecchiare tutta la giornata, e un po’ intontito andò appresso all’asino, una pecora si decise a passare il varco: allora come tirate da un filo invisibile una dopo l’altra o a due a due uscirono le altre, sempre col muso a terra, con le faccie una diversa dall’altra ma tutte trasognate e buone.
In mezzo andava il montone, belando grosso; in ultimo seguivano gli agnellini zoppicanti, come le nuvolette che si sperdono dietro le nuvole grandi.
Una nebbia di polvere camminava con loro, e il pecoraio fischiava trascinando il bastone e inciampando, senza avvedersi che qualcuno mancava dal gregge.
Ma dovette accorgersene il padrone perché la mattina dopo un altro ragazzo venne con le pecore e stette sempre in mezzo a loro guardandosi torvo intorno.
Anche il figlio dell’ex-terrazziere guardava dalla finestra, con gli occhi stralunati. La madre era andata a fare un po’ di spesa, il padre laggiù per quel bel mestiere.
Egli guardava i prati bianchi di rugiada, la macchia del gregge al sole, il pecoraio e l’asino neri di contro all’azzurro chiaro dell’orizzonte.
Tutto era tranquillo, adesso; i mandorli coperti di migliaia di farfalle bianche, ognuna con due perle di rugiada sulle ali, le pecore che pascolavano in silenzio, l’agnellino giù nella mangiatoia.
Quanto tempo era passato dalla sera avanti? Molto, molto tempo: tutta una vasta notte nera che aveva completamente cambiato l’aspetto delle cose versandosi sul mondo come una macchia d’inchiostro sulla pagina bianca del quaderno.
Dalla finestra il ragazzo sentì la tosse della madre: si ritirò e si mise a studiare.
Quando ella entrò col suo fazzoletto della spesa, egli sentì un cattivo odore, un odore di baccalà guasto, e pensò al padre e gli venne da vomitare come quando s’era stretto il fazzoletto al collo.
Si alzò di scatto e prese la posizione di quando il professore lo interrogava.
– Mamma, devo dirti una cosa: ieri, mentre eravate fuori, un agnellino qui del gregge è entrato nella stalla; io mi ci sono messo a giocare, l’ho preso fra le braccia e si vede che l’ho stretto assai perché è morto. Vieni a vedere; è giù.
– Tu sei pazzo – gridò la madre, poi fu presa da un colpo di tosse che le impedì di continuare; tuttavia seguì il ragazzo, e tirò su lei l’agnello già un po’ rigido e con gli occhi spalancati di vetro nero.
– Come si fa, adesso; è un bell’impiccio – disse finalmente, guardandolo da tutte le parti. – Tuo padre, poi!
– Io direi di scorticarlo, mamma. A papà si dice che l’hai comprato, per Pasqua. Adesso si può comprare qualche cosa, accidenti! Siamo così miserabili perché viviamo sempre d’erba come le pecore. E papà adesso ha diritto a mangiar bene.
Era arrabbiato, il ragazzo, e la madre non protestò; pensava piuttosto da chi far scorticare l’agnello, poiché lei non era buona.
E il giorno di Pasqua il padre, che già portava a casa le mancie, ed era stato a comunicarsi, approvò la moglie di aver comprato l’agnello. Da tanto tempo non se ne mangiava: e lo mangiò quasi tutto lui, perché la moglie a causa della tosse non aveva mai appetito, e il ragazzo non ne volle. Era un po’ stralunato, il ragazzo, forse perché studiava troppo: nel vedere che il padre rosicchiava le ossa con voluttà ferina si mise però a ridere.
– E perché ridi adesso? Egli non lo disse, anzi ricadde nel suo fantasticare. Pensava ai preti che proteggevano il padre per la sua devozione. Se avessero saputo! Eppure anche lui, nel caos che turbinava nella sua coscienza, ritrovava confusamente un senso di mistero religioso.
Aveva piacere che il padre godesse: che l’agnello fosse sacrificato a lui come al padre dei cieli.